Per una nuova interpretazione de “La Chimera”: un quadro degli Uffizi di Walter Scarpi
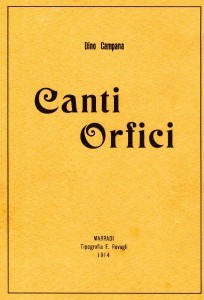
La Chimera, una delle prime poesie pubblicate da Dino Campana, esce con il titolo “Montagna – La Chimera” sul foglio goliardico bolognese Il Papiro nel 1912. Inclusa nel 1913 nel manoscritto rimasto inedito fino al 1971 de “Il più lungo giorno”, dove appare già modificata nella sua redazione pressoché definitiva, viene stampata nei “Canti Orfici” nel 1914 come primo dei sette notturni che seguono la sezione di apertura dal titolo La Notte. In una lettera a Prezzolini1 (6 gennaio 1914) Campana la presentava così: «Scelgo per inviarle la più vecchia la più ingenua delle mie poesie, vecchia di immagini, ancora involuta di forme: ma Lei sentirà l’anima che si libera».
L’intera composizione, ricca di effetti assai suggestivi ma involuta di forme, irrisolta in passaggi avvertiti dall’autore come non ancora compiutamente sbocciati ma ormai cristallizzati in forme non più modificabili, poggia su un linguaggio simbolico e allusivo, iniziatico ed ermetico di non facile decifrazione, continuando a presentare a tutt’oggi autentici problemi di lettura in più punti, a cominciare dall’identificazione stessa della chimera.
La chimera di Campana sembra alquanto distante dall’omonima creatura mostruosa della mitologia classica. La parola, in senso figurato, significa invece: ipotesi assurda, sogno vano, utopia. Più che un incubo, un sogno. Questo soggetto misterioso è stato variamente interpretato dalla critica2 come “una figura femminile ideale” e allo stesso tempo “una figurazione della poesia” (Fiorenza Ceragioli), un’“Illusione eterna dell’uomo, antica e misteriosa ansia d’amore” (Neuro Bonifazi). Sulla scorta anche di un altro passo campaniano da la Notte («l’eterna Chimera teneva fra le mani rosse il mio antico cuore») può essere una “pura espressione di desiderio” o “una figura femminile di casa di tolleranza”, come scrive Asor Rosa; può essere la luna-Proserpina e “regina del ricordo”, sorella della Gioconda, della Vergine delle Rocce, di Santa Cecilia, e “regina dei sogni”. Silvio Ramat propone un collegamento fra la Chimera triforme (leone, capra, serpente), tre arti (pittura, danza, musica) e tre vergini misteriose (la vergine delle rocce di Leonardo, Proserpina e Santa Cecilia di Raffaello).

Per decenni, nella mia pratica di lettore comune, ho dato a questa lirica il senso per me più semplice, diretto, intuitivo. Ho immaginato un incontro reale avvenuto per strada, a Marradi o in un luogo circondato similmente da monti: il giovane poeta incrocia una ragazza e rimane colpito all’istante dal suo volto; per pudicizia, per sottrarsi all’imbarazzo di quello sguardo maschile colmo di appassionata meraviglia, l’adolescente china la fronte e prosegue il cammino.
Ma ecco che rileggendo nuovamente “La Chimera” in questi giorni mi sono concentrato sull’analisi dei sei versi finali e per la prima volta, trovandoli disomogenei, ho avuto l’impressione che possano non riferirsi a un panorama unico, un paesaggio montano reale che il poeta ha (oppure immagina di avere) davanti, ma piuttosto a una successione di quadri diversi visti in un museo o forse a una serie di dettagli di un solo quadro. L’intera composizione è d’altra parte intessuta di riferimenti puntuali a quadri, tele dipinte, opere leonardesche. Ho quindi, infine, provato a immaginare che la figura della chimera (simbolo della poesia e dell’arte, dell’amore risolutivo e irraggiungibile anche quando mercificato, comunque illusione eterna secondo le interpretazioni correnti con le quali in sostanza non sono in disaccordo) possa provenire anch’essa dalla visione di un quadro.
il saggio completo di Walter Scarpi

